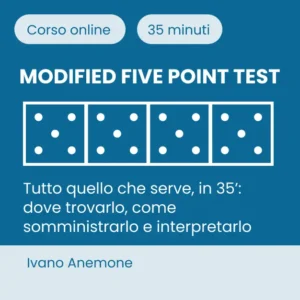Il “discorso interiore” (inner speech), comunemente identificato come la “vocina nella testa” o il pensiero espresso in parole, è un fenomeno mentale che attrae un notevole interesse per la sua intersezione con linguaggio, coscienza e memoria.
Nella lettura silenziosa, la sua manifestazione principale è la subvocalizzazione, ovvero l’atto di articolare mentalmente le parole.
Questa pratica viene spesso etichettata come un ostacolo insormontabile per la lettura veloce, limitando i lettori alla velocità del parlato (80–230 parole al minuto).
Tuttavia, un’analisi approfondita rivela una dicotomia fondamentale: sebbene la subvocalizzazione possa rallentare la lettura, essa è contemporaneamente un meccanismo cognitivo cruciale per la ritenzione e la comprensione.
Per comprendere la resistenza del discorso interiore, è necessario considerare la sua natura evolutiva, come descritta dal quadro socioculturale di Lev Vygotsky.
Il discorso interiore non è semplicemente un meccanismo di memoria, ma il prodotto finale di un processo di internalizzazione che trasforma il linguaggio sociale in pensiero verbale.
Vygotsky riteneva che il pensiero non fosse semplicemente espresso in parole, ma che venisse realizzato e modificato attraverso di esse.
Questo processo, che evolve dal dialogo esterno al linguaggio privato, culmina in un discorso interiore che è sintatticamente condensato rispetto al parlato esterno.
Questa prospettiva colloca la subvocalizzazione all’interno della lettura come una funzione covert cruciale che supporta l’acquisizione del processo stesso, ben oltre la mera ripetizione.
Dal punto di vista della psicologia cognitiva, l’inner speech è il fondamento del phonological loop, un sistema di Memoria di Lavoro (WM) che si basa sulla ripetizione articolatoria silenziosa e sulle immagini uditive per mantenere l’informazione.
La subvocalizzazione funge da rehearsal elaborativo, permettendo al lettore di trattenere i codici fonologici delle parole decodificate nella Memoria a Breve Termine (STM).
Studi come quelli condotti da Pollatsek e colleghi (1992), che hanno impiegato il paradigma della moving window, hanno dimostrato come la codifica fonologica non sia accidentale, ma essenziale.
Essa facilita l’accesso al significato lessicale e supporta l’integrazione di informazioni attraverso i movimenti oculari saccadici.
Senza questo codice fonologico, la capacità di elaborare e trattenere informazioni da frasi complesse diminuirebbe drasticamente.
L’eccessiva enfasi sulla velocità ha portato molti metodi ad adottare la soppressione forzata della subvocalizzazione.
Tuttavia, l’evidenza sperimentale dimostra che questa strategia è controproducente: i partecipanti che leggono senza subvocalizzazione ottengono performance inferiori nei test di comprensione del testo.
Ciò indica che la subvocalizzazione è un tool di supporto essenziale—un aiuto per la decodifica, la memoria e la concentrazione—e non la radice della lentezza.
I lettori abili non eliminano il discorso interiore; piuttosto, imparano a modularlo. Essi fluttuano tra un processing rapido (semi-automatico o visivo) e un processing più lento e subvocalizzato (parlante) a seconda della complessità o dell’importanza del materiale.
La subvocalizzazione è un componente ineludibile e necessario del processamento profondo del testo. Il vero segno distintivo di un lettore esperto non è la sua capacità di leggere senza la “vocina,” ma la sua flessibilità nel modularla.
Il training cognitivo prepara il lettore a utilizzare il discorso interiore non come un freno, ma come uno strumento strategico di autoregolazione e come un “coach positivo” per la concentrazione.10
L’obiettivo è automatizzare i processi fonologici affinché l’attenzione cosciente possa essere interamente dedicata alla comprensione semantica complessa.
Craik, F. I. M., & Watkins, M. J. (1973). The role of rehearsal in short-term memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 12, 599–607.
de Guerrero, M. C. M. (2006). Inner Speech – L2: Thinking Words in a Second Language (Vol. 6 of Educational Linguistics). Springer Science & Business Media.
Pollatsek, A., Rayner, K., & Balota, D. A. (1992). The role of phonological codes in integrating information across saccades in reading. Perception & Psychophysics, 51(2), 173–182.
Vygotsky, L. S. (1986). Thought and language. Cambridge, MA: MIT Press.
![[Corso asincrono] Disortografia: il potenziamento della scrittura. Strumenti pratici.](https://www.trainingcognitivo.com/wp-content/uploads/2026/01/Corso-asincrono-Disortografia-potenziare-scrittura-1-300x300.png)
![[Corso asincrono] Discalculia: compensare e potenziare le abilità matematiche.](https://www.trainingcognitivo.com/wp-content/uploads/2025/11/Corso-asincrono-Discalculia-compensare-e-potenziare-le-abilita-matematiche-300x300.png)
![[Corso asincrono] Le funzioni esecutive nei Disturbi Specifici dell'Apprendimento](https://www.trainingcognitivo.com/wp-content/uploads/2026/01/Corso-asincrono-Le-funzioni-esecutive-nei-DSA-2-300x300.png)